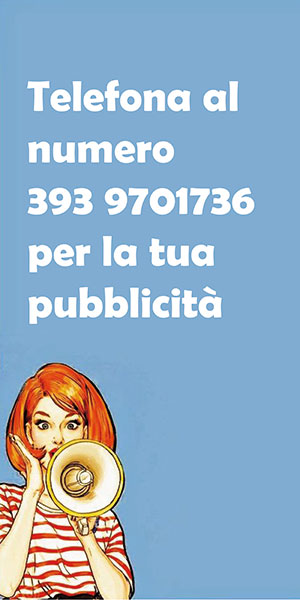di Fernando Di Fabrizio
“… Ma il Comune dice che però la città è moderna
Non ci devi far caso se il cemento ti chiude anche il naso
La nevrosi è di moda
Chi non l’ha ripudiato sarà
Ahia non respiro più…
Mi sento che soffoco un po’
Sento il fiato che va giù
Va giù e non viene su
Vedo solo che qualcosa sta nascendo
Forse è un albero
Sì è un albero di trenta piani”.
Adriano Celentano nel 1972,anticipando di oltre mezzo secolo, i problemi legati all’inquinamento climatico in Italia, lanciava il suo appello ecologista con la canzone “Un albero di trenta piani”. I versi che aprono questo articolo sono riferiti all’ultimo brano della canzone. Il presagio di Celentano, tristemente attuale, con la situazione ambientale italiana che in alcune aree continua ogni giorno a peggiorare, ci rivela oggi un futuro ancora più incerto. Con la canzone precedente “Il ragazzo della via Gluck” del 1966 il cantante ecologista si chiedeva “come si farà… se continuano a costruire le case…”.
Perché continuano a costruire le case
E non lasciano l’erba
Non lasciano l’erba
Non lasciano l’erba
Non lasciano l’erba
Eh no Se andiamo avanti così,
chissà Come si farà
Chissà Chissà Come si farà
La nascita dei primi movimenti ambientalisti italiani, in quel periodo, portava all’attenzione del vasto pubblico, da poco uscita dalla tragica guerra mondiale, il tema delle città che divoravano ovunque le campagne periferiche. Con “Le mani sulla città” un film drammatico italiano del 1963,il regista Francesco Rosi svela il suo impegno civile con una spietata denuncia della corruzione e della speculazione edilizia dell’Italia degli anni sessanta. Significativa è la didascalia del film che recita: “I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce.” Ancora più chiaro appare il dialogo tra due personaggi del film “Il denaro non è un’automobile, che la tieni ferma in un garage: è come un cavallo, deve mangiare tutti i giorni”(Edoardo Nottola, rivolto a Maglione). Ed è osservando le campagne dei cavalli di Piano di Sacco a Città Sant’Angelo invase in questi giorni da decine di ettari di impianti fotovoltaici il motivo che mi spinge a scrivere questa “inutile riflessione” sul consumo di suolo.
Nei primi decenni del dopoguerra i piani regolatori generali delle città consentivano l’urbanizzazione delle campagne a “macchia di leopardo” senza una vera programmazione territoriale, eppure oggi nonostante sono passati tanti anni da quel difficile periodo, assistiamo inermi ad un vero attacco alle ultime campagne coltivate con estesi impianti di produzione di energia fotovoltaica, senza nessuna considerazione per i valori agroecosistemici, condizionando e banalizzando per sempre intere aree di pregio paesaggistico, naturalistico e ambientale. In Sicilia sono previsti insediamenti grandissimi fino a 600 ettari, anche in Abruzzo non si resta indietro nella folle corsa del consumo del suolo, nel basso Chietino sono previsti impianti di 40 e perfino 80 ettari, sulle fertili campagne del paesaggio mediterraneo. Purtroppo anche nel bacino del Tavo e del Fino cominciano ad apparire impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che invadono prepotentemente e in maniera definitiva le splendide campagne vestine, rimaste intatte per migliaia di anni. A nulla servono gli appelli delle associazioni agricole e ambientaliste, dei singoli esperti e di qualche sindaco, che implorano, istituzioni e imprenditori ad evitare i terribili impatti sul paesaggio, sempre più devastato dagli interventi antropici.
Siamo passati dalle Mani sulla città alle Mani sulle campagne, i due aspetti sono collegati da un sistema “drogato” delle agevolazioni pubbliche, per le imprese che vogliono investire nella produzione energetica con impianti davvero impattanti dove la trasformazione e dunque il consumo dei suoli agricoli si trasforma in un lampo in aree produttive industriali. Ancora una volta la storia si ripete, dalla speculazione edilizia degli anni ’50 e ’60 dove spesso le necessità urbanistiche dei centri urbani italiani erano spinte dall’esigenza della ricostruzione post-bellica, all’invasione del fotovoltaico nelle campagne sanciti dai due Decreti Ucraina emanati dopo lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina. Le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono estese dai 300 ai 500 metri nelle campagne agricole che si trovano intorno a stabilimenti industriali, cave e miniere, e dai 150 ai 300 metri quelle collocate nelle fasce adiacenti alle autostrade. Si potrebbe pensare che un grande impianto nei pressi di un area industriale non dovrebbe comportare un impatto ambientale perché l’area è già compromessa.
In realtà se prendiamo in esame le aree cosiddette industriali dei piccoli centri appenninici, ci accorgiamo che ci troviamo in aree praticamente agricole dove gli impianti fotovoltaici di centinaia e migliaia di ettari verranno realizzati attorno alle improbabili aree artigianali, praticamente senza nessun servizio annesso, e spesso praticamente inesistenti. Tutto questo comporterà l’inesorabile consumo del pregiato suolo agricolo, magari attorno ad un solo piccolo capannone come è il caso di Montebello di Bertona o anche più insediamenti per lo più abbandonati a Piano di Sacco di Città S. Angelo.
Ci troviamo di fatto di fronte ad un vero “imbroglio ecologico” secondo la mia visione territoriale. Cercherò di spiegare i motivi che mi costringono ad esprimere una considerazione così netta. Una buona gestione del territorio dal punto di vista urbanistico comporta la suddivisione dell’area comunale per zone omogenee, accomunate da specifiche destinazioni d’uso, la zonazione del territorio ormai viene applicata perfino nei Piani dei Parchi Nazionali. Due direttive europee, la 42/2001, legata alla sostenibilità, impone a piani e programmi di un certo rilievo territoriale la procedura della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), prevedendo il coinvolgimento delle comunità locali nell’analisi dello scenario, mentre la 35/2003 sancisce la necessità di attivare processi di partecipazione territoriale. Naturalmente la costruzione dei grandi impianti fotovoltaici che rientrano nei 500 metri delle aree industriali non rientrano nel concetto di partecipazione sociale e spesso neppure i sindaci sono messi in condizioni di esprimere un parere vincolante. A Loreto Aprutino recentemente i sindaci della valle del Tavo insieme alle organizzazioni e imprese agricole e alle associazioni ambientaliste hanno manifestato la propria contrarietà per la costruzione di impianti elettrici fotovoltaici impattanti in contrada di Remartello.
Ma facciamo un esempio concreto. Sulla collina di Collalto a Penne sorge il primo Centro di Educazione Ambientale della Regione Abruzzo, nel cuore della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne. Migliaia di visitatori possono ammirare un paesaggio ancora integro e ben conservato, anche nel corridoio di soli due km che separa la Riserva dal grande Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nei territori di Montebello di Bertona e di Farindola. In questa piccola fascia è localizzata l’area artigianale del Comune di Farindola dove però non ci sono insediamenti impattanti.
Dunque per il Comune di Farindola, che nel suo territorio montano conserva ambienti straordinari come la Valle d’Angri ma anche la splendida Faggeta della Pelinca o del Monte Guardiola, la contrada Case Bruciate a Ridosso di Collalto è di scarso interesse naturalistico. Invece per il Comune di Penne, che ha chiesto e ottenuto l’istituzione di una Riserva Regionale la fascia collinare tra il fiume Tavo e il torrente ,la stessa area è di grande pregio naturalistico. La domanda che ci poniamo è questa: Collalto è un’area di pregio oppure di scarso valore? Un eventuale impianto fotovoltaico nell’ambito di un’area industriale (inesistente nella realtà ma pianificata nella carta) è compatibile con la vocazione naturalistica del territorio protetto?
E ancora, più a valle è lecito realizzare impianti fotovoltaici nei terreni agricoli dove sono stati spesi numerose risorse pubbliche per irrigare migliaia di ettari fertili che dovrebbero smettere di produrre risorse alimentari di qualità?
Dopo la tragedia Covid milioni di italiani hanno cominciato ad apprezzare gli ambienti naturali frequentando boschi, montagne, colline e campagne, l’utilizzo sociale del territorio deve essere considerato un bene comune. Gli impianti fotovoltaici si possono realizzare sopra i tetti e nelle vere aree industriali… ma non dovrebbero compromettere le aree di pregio e il futuro delle prossime generazioni. Occorre oggi evitare il conflitto sociale per il bene comune, cercando di rinunciare ai progetti impattanti in aree vocate alla fruizione sociale, agricola e naturalistica. I cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità sono due punti essenziali da valutare nella definizione dei programmi territoriali.
L’Impatto del consumo di suolo sull’intero pianeta comporta infatti la Perdita di biodiversità con distruzione degli habitat naturali e agroambientali, mettendo a rischio molte specie di piante e animali. La degradazione del suolo comporta la trasformazione del terreno con eventuale erosione, perdita di fertilità e compattazione del suolo. Gli impatti ambientali riducono inoltre le risorse idriche già scarse e insufficienti. Il consumo di suolo altera il ciclo idrologico, riducendo la capacità del suolo di assorbire e immagazzinare acqua. Le strategie per mitigare il consumo di suolo comprendono: una Pianificazione urbana sostenibile con la promozione dell’uso efficiente dello spazio e la riqualificazione delle aree dismesse. La protezione delle aree verdi con la creazione di parchi e riserve naturali per conservare gli habitat naturali. L’Agricoltura sostenibile per implementare pratiche agricole che preservino il suolo e la biodiversità. Le Politiche di gestione del territorio adottando regolamenti che limitino la conversione del suolo e incentivino l’uso sostenibile del territorio.
Queste semplici azioni possono contribuire ad evitare la distruzione degli habitat con l’estinzione delle specie che vi abitano. Le specie endemiche, che vivono solo in particolari regioni, sono particolarmente vulnerabili. La frammentazione degli habitat limita il flusso genico tra popolazioni di specie, riducendo la variabilità genetica e la capacità delle specie di adattarsi ai cambiamenti ambientali. La perdita di specie chiave può alterare significativamente gli ecosistemi, influenzando le catene alimentari e i cicli dei nutrienti. Affrontare il problema del consumo di suolo richiede un approccio integrato e la collaborazione tra governi, comunità locali e settori industriali, per garantire uno sviluppo che sia sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
Il consumo di suolo e la riduzione della biodiversità sono strettamente collegati e rappresentano due delle principali problematiche ambientali globali.
Fernando Di Fabrizio Direttore Riserva Naturale Regionale Lago di Penne